Antoine Garapon è un saggista e magistrato francese noto a tutto il grande pubblico per l’impegno intellettuale che lo ha portato, nel corso della sua carriera, a pubblicare numerosi saggi e a realizzare trasmissioni radiofoniche dedicate al diritto e alla giustizia. Oltre ad aver svolto per diversi anni la funzione di giudice dei minori, ha sempre affiancato alla professione altre attività di spicco: coeditore della rivista francese Esprit, direttore della collana Bien commun delle Editions Michalon, ha fondato e presieduto, fino al 2020, l’Institut des hautes études sur la justice, ed è presidente della Commissione di riconoscimento e riparazione creata dalle congregazioni religiose dopo la pubblicazione del “rapporto Sauvé” per le vittime dei religiosi e religiose. Dottore di ricerca in diritto e autore di più di trenta opere in ambito giuridico-filosofico, l’ultima è “Processo penale e forme di verità” (Mimesis, 2024), da cui è nata l’occasione per incontrarlo e intervistarlo. Il libro raccoglie quattro contributi inediti che ruotano attorno alla funzione del processo rispetto alla ricerca della verità. Garapon ha voluto condividere le proprie riflessioni sul tema, dibattuto dalla dottrina processual-penalistica, con l’Università degli Studi di Bologna, proponendone una lettura che travalica i confini netti del diritto. In primis, affronta la questione dal punto di vista del simbolismo giudiziario; poi, da una prospettiva più antropologica tramite l’analisi di un articolo di Marcel Hénaff; dunque, considera il significato delle ordalie, procedure probatorie basate sul “giudizio di Dio”; infine, mostra i paradossi che si contrappongono all’influenza esercitata dalla cultura giuridica americana nell’era della globalizzazione.
*crediti foto in calce all’articolo
La verità, nella sua ultima opera “Processo penale e forme di verità”, può essere considerata un simbolo? E se sì, quale immagine deve (o dovrebbe) evocare nella mente collettiva?
L’importante è comprendere perché una società riconosca una determinata assunzione come vera. Questo è l’aspetto che più m’interessa. Nella mia riflessione ho preso spunto da Foucault che, come Nietzsche, ritiene che non esista una verità, ma solo delle procedure di verità. Anche io, come Foucault, sostengo che vi siano delle forme di verità, in virtù delle quali la società considera una proposta o una decisione dell’istituzione come vera, che si tratti di una legge, un tribunale o un voto politico. Una società è disposta a riconoscere le verità che rendano giustizia secondo riti e formule, anche di tipo simbolico; perciò, l’immagine a cui associamo la verità non è nient’altro che la stessa giustizia.
Le teorie procedurali sono tre: il processo penale come confine di verità sull’imputazione; il processo penale come soluzione di conflitto tra le parti; il processo penale come gioco senza scopi. Quale di queste tre teorie, secondo Lei, è la più corretta, ossia quella che si sposa meglio con il Suo concetto di verità?
Direi che il processo è un gioco serio. Sì, ciascuno ha il suo ruolo, ma in funzione di uno spettacolo serio, produttivo di una proposta. Quando si dice gioco, teatro, ci si induce a pensare che sia artificioso, inautentico. Il processo è la combinazione di un aspetto “ludico” con la separazione tra le parti, che in fondo mira a proteggere le libertà di ciascuno. Inoltre, il processo fa tante cose nelle stesse forme: i giuristi ritengono sia uno scambio di argomentazioni, e non hanno consapevolezza della ricaduta sociale della loro attività; i drammaturgi ne vedono una mise en scene di un caso; gli antropologi ne vedono una regolazione della violenza e parlano di cose che appartengono alla loro conoscenza, come sacrifici e simboli connessi alla loro disciplina. Tutto ciò è vero. I giuristi stessi, sebbene siano la leadership di ciò che succede durante il processo, non sanno tutto quello che serve sapere. I giuristi, siano questi avvocati, giudici o poliziotti, non hanno dimestichezza di tutta l’interezza di ciò che necessitano sapere. Fanno il loro lavoro, ma le logiche sociali possono attraversarli senza che ne abbiano coscienza. C’è uno studio molto famoso di Abraham Bloomberg a New York, che s’intitola The practice of Law and the Confidence Game. In questo studio l’avvocato pensa di difendere il cliente, ma Bloomberg, come sociologo, sostiene che prepara il cliente al gioco giudiziario: insegnandogli a giocare, a esprimere le sue emozioni ecc. Ecco, si tratta di un modo diverso di vedere l’avvocato.
La verità, in base alla sua esperienza di magistrato, consiste nel capire o nel sapere?
Nel sapere. La verità consiste in primis nel sapere, per stabilire dei fatti. Una volta che i fatti sono stabiliti, possiamo provare a capire. Vi è un rischio a considerare le cose nel senso opposto. Per esempio, in materia di abusi sessuali: se si cerca di comprendere la personalità prima di giudicarla, questo falsifica il giudizio. Quindi, per completare la risposta, direi che bisogna stare attenti alla tentazione di capire prima di sapere.
Glauco Giostra, nella sua “Prima lezione sulla giustizia penale”, definiva il processo la via meno imperfetta per cercare di attingere alla verità nel contesto storico, culturale e scientifico in cui andrà a operare. Secondo lei, il processo penale ha ancora questa funzione? O prevalgono altri interessi?
Cambia lo scenario a seconda dei tipi d’infrazione, di reato. Direi però che il processo rimane la via più giusta quando vi è un conflitto radicale sull’effetto o sulla finalità della giustizia. Per esempio, in materia di criminalità organizzata, a cui si legano importanti questioni di sicurezza collettiva, il processo è la direzione migliore: i fatti sono contestati, gli accusati sono ben consigliati e preparati, ecc. Il processo è la via più appropriata in quanto offre delle garanzie rispetto a soluzioni più rapide ed efficaci che, invece, travolgerebbero qualsiasi tipo di garanzia dell’accusato. Trattasi di saggezza accumulata da millenni, quindi è ciò che c’è di meglio. A dirla tutta, vi sono forme di violenza che sono governate da altre regole, al di là di quelle processuali, ma resterei sul processo. Che sia anglo-americano, italiano o francese, rimane comunque la via ideale per le persone che hanno aggredito l’ordine sociale in maniera deliberata, intenzionale. Poi, per i casi familiari e altri dossiers, è possibile individuare altre vie per trovare la verità: una verità più umana, più attiva, poiché la soluzione del processo penale potrebbe addirittura portare effetti peggiori. Qui, bisogna trovare forme diverse, altre maniere. Una di queste è, ad esempio, la mediazione. Bene, un momento, ora riformulo la mia risposta in maniera più giuridica! Se la posta in gioco consiste in anni di prigione di fronte ad una problematica socialmente importante, che minacci le libertà, il patrimonio o l’onore, allora c’è bisogno di garanzie. Le garanzie sono forme e, come tali, devono essere rispettate. In altre situazioni, laddove non ci sia la ricerca delle vendetta, o di un ristoro o di un “avere”, il punto di vista più importante, prima ancora di quello sociale, è di natura umana, interiore. In questi casi, è possibile portare avanti l’interesse di un riconoscimento dell’atto, per la pace interiore. Ecco, in questi casi, a mio avviso, bisogna ripensare all’utilizzo che facciamo della giustizia. Oggi, per esempio, abbiamo a disposizione degli studi seri e approfonditi su ciò che vorrebbero le vittime di violenza sessuale. Certe vogliono vendetta, delle altre vogliono una riparazione. È molto sottile, subdolo. Parlo anche alla luce della mia esperienza con vittime di violenza sessuale. Noto come bisognerebbe fare molta più attenzione, più riflessione su ciò che vuole una vittima e come permettere alla vittima di dire quello che vuole. Un esempio: le associazioni femministe lottano contro l’ordine patriarcale, contro l’impunità. Ma perché solo il 7% delle vittime portano avanti una denuncia? Può darsi perché non sono soddisfatte della pubblicità, delle inchieste della polizia, degli esperti, del giudizio morale? L’umiliazione e la sfiducia rispetto a quello che potrebbe offrire un processo penale deriva dalla sua tendenza all’ottenere, all’avere, e non all’essere. Vi è una nozione che è interessante per la verità: l’imparzialità epistemologica, cioè l’assenza di una comprensione dei fatti. Io sono un uomo rispettabile, che non si fa problemi a prendere la metro a Parigi, ma una ragazza, invece, potrebbe sentirsi in pericolo dovendola prendere, specialmente se di sera, in una zona periferica e se non è francese. L’imparzialità epistemologica è aspettarsi che il giudice sia capace di comprendere soggettivamente l’esperienza di una giovane donna immigrata che prende la metro a mezzanotte a Château. Dal mio punto di vista, c’è ancora molto lavoro da fare.
*foto ricavata dal profilo di autore di Antoine Garapon su Criminal Justice Network
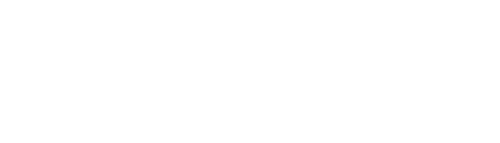

Commenti recenti