Don Claudio Burgio, co-fondatore della Comunità “Kayros”, ci apre le porte di un’esperienza venticinquennale che ha rivoluzionato il modo d’intendere il recupero dei minori a rischio. “Kayros” non è solo una comunità, ma un vero e proprio laboratorio di rinascita, dove il kronos (il tempo della pena) si trasforma in kayros (il tempo dell’opportunità). La sua visione è chiara: «La vera sicurezza si costruisce offrendo ai ragazzi opportunità e percorsi di crescita». L’intervista mette in luce l’importanza cruciale della personalizzazione dei percorsi di recupero, illustrata dall’esperienza di Zaccaria Mouhib, rapper altrimenti noto come Baby Gang. Di fronte a un ragazzo che esprimeva il desiderio di diventare cantante, Don Claudio ha dimostrato che una comunità non deve imporre standard, ma favorire la ricerca di sé attraverso progetti educativi unici.
*crediti foto in calce all’articolo
Può raccontarci, Don Claudio, come nasce l’associazione “Kayros”? In che rapporto è questo nome con la sua missione associativa, e quali sono state le sue evoluzioni?
“Kayros” è una comunità che è stata fondata da me e altre persone, famiglie e giovani dell’epoca nel 2000. Dunque, ha 25 anni di vita ed è sempre stata caratterizzata da un progetto di accoglienza residenziale per minori, in particolare stranieri non accompagnati. Dal 2005, per mezzo del mio ingresso come cappellano presso l’Istituto Penale per Minorenni Maschile e Femminile “Cesare Beccaria” di Milano, è anche diventata, e tutt’ora lo è, una comunità penale minorile. Accogliamo i ragazzi sia in misura cautelare, sia in messa alla prova, che più in generale in misura alternative alla detenzione. Abitano questa comunità una cinquantina di ragazzi, fra i 14 anni (ora ce n’è uno più piccolo di 13 anni) fino ai 20 anni, all’interno di sette appartamenti più un centro in Vimodrone, alle porte di Milano. Il nostro nome “Kayros” è un nome greco che certamente ha un sapore filosofico, culturale, della grecità e significa letteralmente il “tempo opportuno” o il “momento giusto”. L’occasione, potremmo dire. Questa parola, che spesso ricorre nella Bibbia, si lega ad una visione cristiana in quanto supera quella visione ciclica del tempo, e nel nostro caso risponde non tanto alla quantità ma alla qualità dei rapporti che si stabiliscono all’interno della comunità, fra gli adulti e fra i ragazzi stessi. Il tuo tempo non è contro di te. Il tempo, dunque, è il migliore maestro. Il nostro tempo è quello che abbiamo a disposizione e bisogna sfruttarlo al meglio. L’idea di chi viene nella nostra comunità è quella che non debba solo scontare una pena, far passare i giorni, tempo, nel senso kronos. Deve essere messo in condizioni di avere un’opportunità affinché l’esperienza in comunità non sia solo un’esperienza cronologica che aiuta un ragazzo a fuoriuscire dal circuito penale, ma che dia effettivamente e concretamente delle opportunità. Mi piace definirla una sorta di “fabbrica del talento”. I nostri ragazzi arrivano disorientati dopo un processo e da noi vengono considerati come potenzialità positive, non solo come criminali. Per noi è fondamentale considerare il reato, in quanto è proprio da lì che facciamo partire il percorso di rielaborazione della loro vita. Questo è il senso e lo scopo della nostra comunità.
Quali sono le sfide e le opportunità che si presentano nel rapporto con i minori in questi contesti?
Le prime grandi criticità del rapporto con questi ragazzi sono abbattere, innanzitutto, la distanza. Se esiste una distanza di ruolo fra adulto e ragazzo, l’asimmetria non aiuta il ragazzo a trovare nell’educatore una persona di fiducia. Abbattere questa distanza significa anche per l’adulto immergersi nella storia del ragazzo, quindi del reato, che è semplicemente la punta dell’iceberg. Crediamo che quest’ultimo sia una richiesta inconsapevole di aiuto. Il reato nasconde una serie di problematiche che affondano alle volte nel terreno familiare e/o ambientale. La prima forma di accoglienza è dare lo spazio ai ragazzi di raccontarsi. E come si raccontano? Non certo nella forma a noi più congeniale, logica. I ragazzi si sentono e si raccontano nelle più svariate modalità. Una di queste, che favoriamo indubbiamente, è quella della musica: la musica che ascoltano e creano, nel particolare rap/trap. Siamo stati anche criticati in passato, perché si è pensato che noi volessimo dare esito a questo tipo di musica. Per noi, in realtà, è stata una chiave di accesso alle loro vite. Nelle canzoni scrivevano e raccontavano tutto di loro stessi, tutto ciò che in maniera verbale non riuscivano ad esprimere. Dunque, per noi, la musica è diventata uno strumento privilegiato, così come il teatro. Le rappresentazioni teatrali che portiamo in giro nelle città, nei teatri, nelle scuole, negli oratori, sono un’occasione per esprimersi e raccontarsi di fronte al pubblico. Ecco che ci si comincia a conoscere. Quindi, questi strumenti che per un primo momento non sono direttamente collegati con la dimensione del reinserimento lavorativo e con un progetto di autonomia, creano successivamente le condizioni affinché il ragazzo possa conoscere sé stesso in profondità, permettendo anche a noi di accedere alla sua visione della vita. Questo significa conoscere loro, i quartieri di provenienza, e se manca diventa difficile, considerando che spesso sono ragazzi non consapevoli di ciò che hanno commesso, in special modo se consumatori di sostanze stupefacenti. Un lavoro approfondito e sistematico. Non si tratta di un’accoglienza in comunità che abbia la pretesa che il ragazzo assecondi quattro regole. È fondamentale che il ragazzo possa sentirsi a casa e venga aiutato a comunicare. Io ritengo che la violenza, le mani e i coltelli, si generino laddove manca la parola, la facoltà di esprimersi.
Lei ha operato sia in carcere che in comunità. Quali sono le principali differenze che ha riscontrato in questi due contesti? Come cambiano le dinamiche relazionali e le esigenze delle persone che ha incontrato dentro e fuori dal carcere?
Quando un Istituto Penale per Minorenni assomiglia più ad un carcere è chiaro che prevarica la logica del kronos e la vita al suo interno viene scandita da orari, tabelle: un contenitore rigido di cose da fare. Quindi, il ragazzo dentro un carcere, in una visione deterministica, vive una spersonalizzazione proprio dove è più importante invece trovare la propria identità. Tanto è vero che il carcere oggi, “quando è troppo carcere”, rischia di diventare una conferma d’identità criminale in età, come quella adolescenziale, molto delicata. Invece, è fondamentale fuori dal carcere personalizzare i progetti di recupero. Non è che ogni ragazzo è uguale all’altro. È necessario differenziare. Il trattamento penitenziario, invece, rischia di avviare un processo di spersonalizzazione della persona detenuta. E con ciò il detenuto, purtroppo, rischia di non essere più una persona e diventa un numero, uno dei tanti utenti che deve sottostare al regolamento dell’istituto penitenziario. Orari identici per tutti, e tutto scandito dal kronos. La comunità, almeno per come l’abbiamo intesa noi, è l’esatto contrario: è una forte personalizzazione dei progetti. Un ragazzo arriva in “Kayros” e in qualche modo ha il proprio progetto, che è unico, originale e irripetibile. Non pretendiamo che si uniformi al progetto di un altro. La messa alla prova, ad esempio, un istituto che permette ai ragazzi di avviare un progetto all’interno o al di fuori di una comunità, non deve essere identico a tutti. C’è chi va a scuola, chi a lavoro e chi ha diverse esigenze rispetto a quello che è lo standard di una classica messa alla prova. Faccio un esempio concreto: con Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, non c’era modo di intraprendere un percorso progettuale che fosse da lui riconosciuto di senso. Lui mi disse: “Io farò il cantante e quindi vorrei venire nella tua comunità”. E io ricordo di aver risposto: “Guarda che se mi dici così, il giudice non ti farà mai uscire dalla tua dodicesima comunità”. Così abbiamo pensato ad un piano “B”, ad un percorso lavorativo o alla scuola. Lui, interrompendomi, mi disse: “Se mi dici così vuol dire che non ti fidi me e che non credi che io possa diventare un cantante”. A quel punto ho pensato: “Ok, vuoi fare il cantante, partiamo da lì”. Quest’esempio serve a dire che io non obbligo a studiare e/o a lavorare se questo progetto non è sentito come proprio. Partiamo da qualcosa che sembra anche lontano da una riabilitazione, ma è qualcosa che davvero è sentita. Nel caso di Baby Gang, a partire dalla musica, si è avviato un percorso durato 4 anni, e il suo progetto musicale ha preso quota. Al di là di questo esempio discografico e artistico, in realtà Zaccaria ha potuto sperimentare attraverso lo strumento della musica, quindi del suo percorso, tutta una serie di nuove consapevolezze. Un percorso che noi abbiamo favorito, anche se non rispondeva in pieno ad un’idea progettuale idonea e confacente ai tribunali. I dubbi dei servizi sociali e dei magistrati c’erano, ma poi hanno capito e l’hanno sostenuto. Quindi, secondo me la differenza deve essere questa. Una comunità non deve standardizzare i percorsi come purtroppo avviene in carcere, ma deve favorire la ricerca di sé stessi sulla base di un progetto rieducativo originale. Vorrei aggiungere anche che i tempi della misura penale non sempre coincidono ovviamente con i tempi di maturazione di un ragazzo. Ad esempio, la nostra comunità offre la possibilità di proseguire il percorso, andando oltre i termini imposti dalla pena: questo ritengo sia giusto. Ovviamente, c’è bisogno di una comunità che sia strutturata in questo modo. Ecco perché una comunità deve essere inserita nel territorio e, allo stesso tempo, deve essere capace di allargare i propri confini. Le comunità chiuse, isolate, difficilmente riescono a portare avanti progetti di senso che vadano oltre i tempi stabiliti.
Nel libro “Non esistono ragazzi cattivi” (Edizioni Paoline, 2010) Lei ha raccontato le complesse biografie di chi ha vissuto la detenzione da minore. Se potesse riscrivere quel libro oggi, dopo tutti questi anni di esperienza, quali nuovi elementi o riflessioni aggiungerebbe? Cosa è cambiato nel mondo minorile e nelle dinamiche che lo caratterizzano?
Infatti, mi hanno chiesto di riscrivere dopo quindici anni un libro, cosa che ho fatto, per Edizioni Piemme. S’intitola “Il mondo visto da qui. Riflessioni di un prete in carcere al tempo delle baby gang”. Ho provato a dire questo: in fondo è vero che sono passati diversi anni, con una pandemia di mezzo, e apparentemente ci sono stati cambiamenti. Secondo me, però, non sono cambiati i ragazzi, ma il mondo adulto. Un mondo adulto che tende a criminalizzare, a vivere questi ragazzi adolescenti come non normali e a stigmatizzarli, talvolta con le migliori intenzioni iperprotettive. Si pretende che quel ragazzo stia dentro certi progetti della vita, e per questo quando esce dalla prestazione, dal risultato atteso, c’è l’ansia del genitore. È cambiata la visione del modo adulto. Lo dico non per negare i problemi che certamente ci sono. È chiaro che i reati degli ultimi anni sono indubbiamente più gravi, anche se non sono in un numero crescente. C’è, però, una mancanza di codice etico, di riferimenti per questi ragazzi, perché vivono in un’epoca dove c’è un vuoto di senso evidente. Fanno fatica a trovarsi in una cultura omogenea che li possa sostenere. Detto ciò, ripeto, è la visione dell’adulto che deve cambiare, in quanto se continuiamo ad avere una visione pessimistica, certamente non aiuteremo questi ragazzi a pensarsi diversamente. Alle volte, ciò che pensiamo di loro è quasi predittivo. Se non c’è dall’altra parte, dal mondo adulto, una capacità di guardare con realismo e speranza al bene di questi ragazzi, il bisogno della sicurezza, di repressione delle condotte, di inasprimento delle pene non può che prevalere. Ormai stiamo andando verso questa frontiera, quella di una sicurezza in cui io non mi trovo. La sicurezza certamente è un bene di tutti, ma non si ottiene inasprendo le pene o mettendo in carcere i ragazzi il più possibile, oppure costruendo nuove carceri minorili o, ancora, abbassando l’età imputabile e cose di questo genere. L’adulto deve abbracciare una visione maggiormente inclusiva e che dà opportunità. Non basta reprimere, perché la vera sicurezza esiste quando un ragazzo sta bene, quando ha opportunità e intraprende percorsi possibili. Dico una cosa concreta: molti ragazzi in ambito scolastico non ci stanno più dentro. Se un ragazzo molla la scuola dopo la terza media o anche prima, la sua fascia di età fra i 14 e i 18 anni è completamente vuota, perché anche il mondo del lavoro, se va bene, è accessibile al compimento dei 16 anni. Ma fra i 14 e i 16? Cosa può fare? Pensate che non possono fare nemmeno il volontariato. C’è una fase di vuoto che, se non è riempita da regolari percorsi scolastici o formativi, purtroppo è riempita dal nulla. Piuttosto che inasprire le pene, cercherei di capire come arginare quei due, tre anni che per molti ragazzi diventano di vuoto totale. È proprio lì che si originano le condotte trasgressive, che a loro volta possono favorire delle devianze vere e proprie. Sono venute meno le opportunità formative e lavorative, di accompagnamento alle fasce deboli di ragazzi.
*foto ricavata dal sito di Kayros
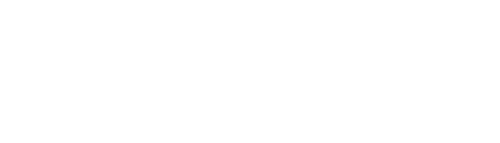

Commenti recenti