L’attuale periodo di emergenza pandemica, che si protrae oramai da oltre un anno, ha senza dubbio alcuno “stressato” le maglie del nostro sistema normativo, evidentemente impreparato ad un simile contesto. La strenua lotta contro la diffusione del Covid-19 e le misure di prevenzione e contenimento del contagio hanno coinciso – in particolar modo per i delitti contro la fede pubblica – con la dilatazione applicativa di varie fattispecie penali, creando un particolare e peculiare contrappasso. Tra i temi più discussi legati agli illeciti di natura penale riguardanti condotte poste in essere durante l’emergenza pandemica, vi è certamente quello relativo al reato di falso ideologico ex art. 483 c.p. per le false dichiarazioni riportate nelle autocertificazioni richieste per giustificare i propri spostamenti in tempi di lockdown. Attualmente stiamo infatti assistendo agli inediti vagli giurisdizionali dei primi casi in cui tale fattispecie è stata contestata, risalenti ai mesi di marzo ed aprile 2020. I provvedimenti ad oggi più significativi sul punto hanno trattato la materia con approcci diversi, tutti meritevoli di approfondimento e da cui ricavare interessanti spunti di riflessione. Il GIP di Reggio Emilia, ad esempio, con sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. resa in data 27 gennaio 2021, ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale da parte del pubblico ministero. In particolare, il caso sottoposto al giudice emiliano riguardava l’autocertificazione rilasciata da una donna che aveva attestato – falsamente – di essere uscita dalla propria abitazione per recarsi in ospedale, in contrasto così con l’obbligo imposto dal D.P.C.M. 8/3/2020. La pronuncia è incentrata sulla delegittimazione delle misure di contenimento del contagio introdotte con lo strumento del D.P.C.M., che il GIP definisce, in maniera categorica e lapidaria, di “indiscutibile illegittimità” proprio nella parte in cui introduce il divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione. Il punto di partenza dell’argomentazione risiede infatti nel vulnus individuabile nella configurazione di un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, che nel nostro ordinamento consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale e, come tale, può essere irrogata solo a seguito di un controllo giurisdizionale, unicamente per determinati reati, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente e, in ogni caso, nel rispetto del diritto di difesa. A conforto di tale affermazione, il GIP elenca alcuni casi di limitazione della libertà personale ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare, ma per i quali viene comunque garantita una convalida del giudice (Corte cost., sent. n. 238/1996): l’obbligo di presentazione alla PG in caso di DASPO; il “prelievo ematico”; l’accompagnamento alla frontiera; il TSO (trattamento sanitario obbligatorio); ovviamente, tutti i casi in cui venga applicata una misura cautelare. Fatta questa premessa, l’art. 13 della Costituzione diventa quindi il perno su cui fondare la decisione, in particolare nella parte in cui prevede la c.d. doppia riserva: le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo con atto motivato dall’autorità e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La riserva di legge limita la discrezionalità del giudice, mentre la riserva di giurisdizione garantisce da provvedimenti astratti e generalizzati, con la conseguenza che qualsiasi provvedimento di limitazione della libertà può riguardare solo specifici soggetti e non anche la generalità dei consociati. Date queste premesse, il GIP rileva che non essendo il D.P.C.M. una legge, bensì una fonte regolamentare di secondo grado (in sintesi, un atto meramente amministrativo), da esso non possano discendere obblighi come quelli sopra indicati. In questi casi, il giudice a quo può autonomamente disapplicare un atto amministrativo senza che sia obbligato a sollevare questione di legittimità costituzionale, pur in presenza di violazione dell’art. 13 Cost. (in virtù dell’art. 5 R.D. n. 2248/1865 all. E, il quale dispone che le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi conformi a legge, ricavandone a contrario che disapplicheranno gli atti amministrativi contra legem).
Come detto, l’illegittimità degli obblighi imposti dal D.P.C.M. 8/3/2020 porta a ritenere non antigiuridica la condotta di compilazione di una falsa autocertificazione – pur materialmente comprovata in atti –, non punibile siccome del tutto inutile (rectius: innocua) e irrilevante. Sul ragionamento seguito dal GIP di Reggio Emilia non sono mancate critiche, non tanto sull’esito della pronuncia, quanto piuttosto sulla configurazione delle misure di cui al D.P.C.M. 8/3/2020 come vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare (mancando un’effettiva coercizione fisica con modalità analoghe agli strumenti detentivi), potendosi trattare al più di un limite alla libertà di circolazione tutelato dall’art. 16 Cost., in relazione al quale è infatti prevista la possibilità che la legge stabilisca in via generale limitazioni per motivi di sanità o di sicurezza. Esistono poi altre pronunce di merito che, invece di soffermarsi sulla (il)legittimità dell’impianto normativo, si focalizzano sull’intrinseca (in)configurabilità del reato ex art. 483 c.p. nei casi di false attestazioni a p.u. (pubblico ufficiale) in contesto pandemico. Vale la pena citare la sentenza assolutoria ex art. 129 c.p., emessa in data 16 novembre 2020 dal GIP di Milano (come nel caso precedente, a rigetto di una richiesta di emissione di decreto penale). Il caso riguardava un soggetto che, richiesto di predisporre l’autocertificazione in occasione di un controllo delle forze dell’ordine, dichiarava l’intenzione di recarsi di lì a poco presso un collega per ritirare alcuni attrezzi che gli sarebbero serviti per lavoro, circostanza questa rivelatasi – a seguito di accertamenti – falsa. La vicenda è di particolare interesse siccome verte sulla sussistenza o meno del reato in caso di falsa attestazione di mere intenzioni, come tali aventi carattere futuro e non ancora realizzate. Il GIP si sofferma sul richiamo alla nozione di “fatto” di cui all’art. 483 c.p. – che sanziona la falsa attestazione al p.u. di “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità” – e di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il rilievo per cui tale tipologia di dichiarazioni risulti estranea all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p. si ricaverebbe, oltre che da una solida giurisprudenza di legittimità sul punto, anche dal dato testuale: “la nozione di fatto non può che esser riferita a qualcosa che è già accaduto […] la cui corrispondenza con la realtà è verificabile solo ex post”; dal profilo teleologico: in un evento non ancora accaduto manca qualsiasi “attitudine probatoria”; in ottica sistematica: i fatti oggetto della dichiarazione probante del soggetto, al pari degli stati e qualità personali, sono caratteristiche che devono essere già presenti al momento della dichiarazione. Su tale impianto argomentativo, del tutto condivisibile, il GIP di Milano rigetta la richiesta di emissione di decreto penale ed emette pronuncia assolutoria. Nelle due pronunce appena citate, il vaglio giurisdizionale si è dunque concentrato, nel primo caso, sulle criticità relative – ab origine – alla legittimità dell’impianto normativo in cui si inseriscono i reati di falso ideologico nelle autocertificazioni rilasciate in periodo pandemico e, nel secondo caso, sull’insussistenza della figura delittuosa nei casi di falsa attestazione di mere intenzioni o fatti futuri. Come porsi quindi in relazione ai casi di falsa dichiarazione riguardanti fatti “già accaduti”?
Una prima risposta di natura giurisdizionale arriva sempre dal Tribunale di Milano, con la recentissima sentenza del 12 marzo 2021. A differenza dei due casi sopra esposti, la pronuncia è resa all’esito di giudizio abbreviato condizionato richiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna e riguarda la contestazione del reato di falso ideologico ex art. 483 c.p. (in relazione all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000), per avere l’imputato dichiarato falsamente di lavorare presso un’azienda di Milano e di fare rientro al domicilio; circostanze, queste, accertate come non corrispondenti al vero. Ancora una volta, assistiamo ad una pronuncia assolutoria con formula piena (“il fatto non sussiste”), motivata però con argomentazioni ben diverse da quelle precedentemente indicate. L’ottica del GIP riguarda un’analisi maggiormente legata alla strutturazione del fatto tipico del delitto di falso ideologico ex art. 483 c.p., muovendo dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui “le false dichiarazioni del privato integrano il delitto di falso in atto pubblico quando sono destinate a provare la verità dei fatti cui si riferiscono, nonché ad essere trasfuse in un atto pubblico”. Ciò equivale a dire che il falso ideologico sussiste solo quando la dichiarazione del privato confluisce in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti ivi attestati. La dichiarazione del privato per cui sussiste l’obbligo di verità è, dunque, solo uno dei presupposti che formano l’atto pubblico a cui si ricollegano effetti giuridici (si pensi ad esempio alle dichiarazioni di reddito, qualità o stati personali per ottenere agevolazioni, benefici, idoneità a partecipare a gare pubbliche, ottenere certificazioni ecc.). Ebbene, nel caso di specie, il giudicante si chiede quale sia l’atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele è destinata a confluire, di fatto non trovando alcuna convincente risposta. Infatti, se si ipotizza che nei casi in oggetto tale atto pubblico coincida con il verbale di contestazione di sanzione amministrativa o con il verbale di identificazione (all’epoca la condotta veniva sanzionata ex art. 650 c.p.), si giunge a conclusioni fallaci e in contrasto con i più basilari principi dello Stato di diritto. In maniera del tutto condivisibile, il giudice afferma che tale obbligo “si porrebbe in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo (art. 24 Cost.) e con il principio nemo tenetur se detegere, in quanto il privato, scegliendo legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative, verrebbe comunque assoggettato a sanzione penale per le false dichiarazioni rese”. Pertanto, lo stesso dà atto che “non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica che ricolleghi specifici effetti ad uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale”. È quindi con questa ulteriore argomentazione che si giunge alla pronuncia assolutoria. In conclusione, esiste certamente il rischio che – soprattutto a causa delle errate traduzioni a livello mass-mediatico – le richiamate pronunce sortiscano effetti pericolosi in un momento delicato come quello attuale, in cui si richiede alla cittadinanza un’assunzione di responsabilità per fronteggiare quella che ormai è la terza ondata del contagio. Tuttavia, le considerazioni di diritto rese nelle sentenze sopra richiamate ci portano una volta di più a riflettere in generale sull’espansione (verrebbe quasi da dire “pandemica”) del ricorso a strumenti sanzionatori di natura penale, spesso e volentieri confliggenti, come abbiamo notato, con principi basilari del nostro sistema normativo e di diritto.

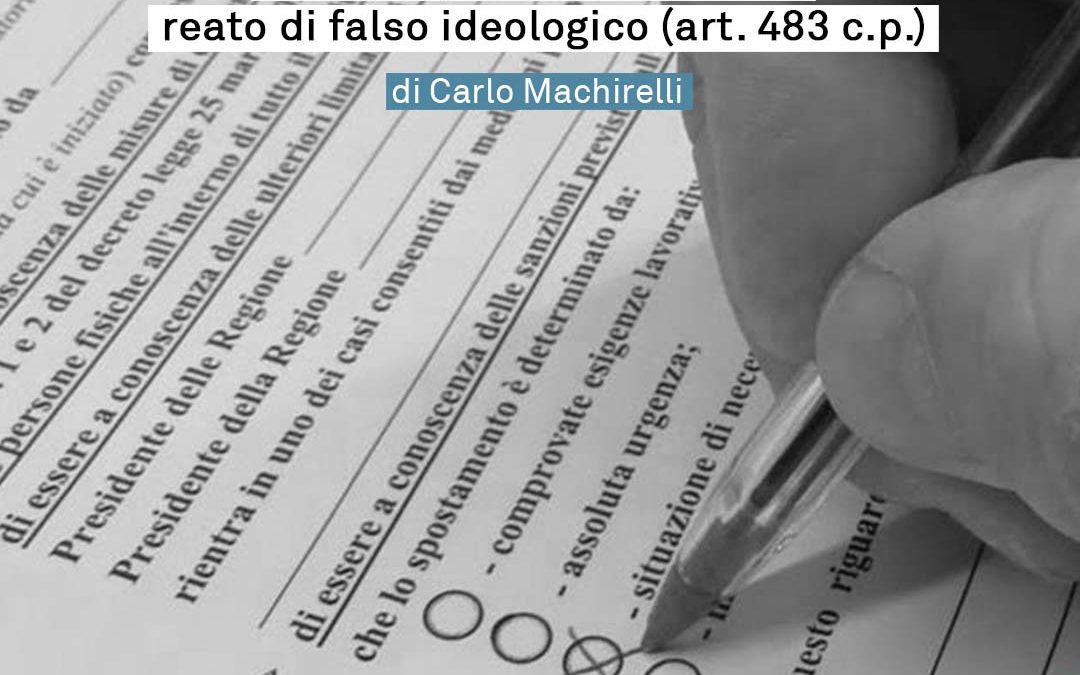
Commenti recenti