«Io credevo di aver scritto un libro sugli anarchici, ma forse ho scritto un libro sullo Stato di diritto, perché il problema che mi sembra d’individuare è dentro i nostri uffici giudiziari». Lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, a cavallo tra il 2022 e il 2023, è durato più di 180 giorni. Una vicenda nota, che ha attirato le attenzioni e il sostegno di buona parte della società civile. La scia giudiziaria e politica di cui fa parte, però, è ben più ampia e viene da lontano. Per questo motivo, abbiamo raggiunto Mario Di Vito, cronista giudiziario e parlamentare de “Il Manifesto”, nonché autore de “La pista anarchica” (edito da Editori Laterza, 2023), un saggio storico-politico sulla storia giudiziaria degli ultimi trent’anni di anarchismo insurrezionale italiano. Una riflessione ancora attuale, non soltanto per i temi che intreccia (fino a comprendere i confini e le storture della nostra giustizia, che interessano qualsiasi cittadino non meno di Cospito), ma anche in vista del prossimo 19 marzo, quando, davanti alla Corte di Cassazione, verrà discusso il ricorso di Cospito contro la decisione che, poco meno di 2 anni fa, lo ha reso il primo anarchico nella storia italiana ad essere sottoposto al regime speciale detentivo del 41 bis.
*crediti immagine in calce all’articolo
C’è un nervo scoperto del tema che tratti, dichiarato nella premessa e nella nota dell’autore, così sintetizzabile. Per uno Stato, misurarsi con un “nemico”, come in questo caso l’anarchismo d’azione (che è un nemico autodichiarato, per ragioni di filosofia e azione politica), significa dare prova del proprio Stato di diritto. Qual è la sua salute, allora?
È una salute precaria, a mio modo di vedere. Le inchieste sugli anarchici insurrezionali o informali, quindi gli anarchici d’azione, evidenziano questo. A guardare l’entità dei fatti su cui s’indaga, commessi o attribuiti agli anarchici di cui parliamo, ci si scontra con delle inchieste enormi, richieste di condanna spropositate, reati ipotizzati giganteschi che, probabilmente, non trovano riscontro nei fatti e nelle azioni degli anarchici. Lì non è tanto una questione politica, legata al fatto che l’anarchico è un nemico dello Stato, o si definisce tale o si comporta come tale. Da parte dello Stato, in ogni caso, dovrebbe esserci una risposta adeguata ai fatti, non rivolta alle intenzioni o alle idee politiche di chi commette determinati reati. È un po’ un’estensione di quello che quello che viene chiamato “diritto penale del nemico”, teorizzato dal giurista tedesco Günther Jakobs, secondo cui il diritto penale normale si può applicare soltanto a chi riconosce le regole dello Stato, mentre chi, al contrario, si riconosce come un nemico deve essere trattato come tale, con una specie di “legge di guerra”. È una teoria che non sta nei codici e, per quanto mi riguarda, non sta né in cielo né in terra. Spesso, però, sta in queste inchieste. Se prendiamo il caso di Alfredo Cospito, basti pensare che ha ricevuto la condanna più grande (a 23 anni di reclusione) per un ordigno esploso davanti ad una Caserma dei Carabinieri che non ha fatto né morti né feriti. È la sproporzione di cui parlavamo prima, che però non emerge soltanto in fase processuale, ma anche d’inchiesta. Infatti, non è infrequente per gli anarchici arrivare davanti al giudice con un’accusa grave, di terrorismo, e uscirne con una condanna piuttosto tenue, per danneggiamento. Eppure, sono due fatti molto diversi. E la storia che viene raccontata su queste inchieste, come del resto avviene per molte altre, prevede una forte preponderanza del punto di vista di chi indaga, rispetto alla realtà dei fatti e alle sentenze.
Infatti, le inchieste che racconti sembrano ripetere bene o male lo stesso schema. Grandi operazioni di polizia e il tentativo dell’accusa di qualificare giuridicamente i fatti contestati agli imputati come, tutto sommato, delitti-fine di un reato associativo che, però, all’urto con il processo, crolla sempre. Non nel processo “Scripta manent“, in cui è stata riconosciuta l’organizzazione criminale di stampo terroristico in capo ad Alfredo Cospito, Anna Beniamino e Nicola Gai. Dall’altro lato, però, sappiamo che loro facevano parte della FAI informale (Federazione Anarchica Informale), che ha una forte matrice individualistica, tanto da abbracciare un carattere radicalmente antiorganizzativo. Come stanno insieme le due cose?
La premessa è che non bisogna mai confondere la politica con il diritto. Come uno si definisce, non è necessariamente come è definito dalla giustizia. Tuttavia, è vero che l’uso dei reati associativi per le vicende giudiziarie politiche è molto esteso in Italia, più o meno da quasi mezzo secolo, ossia dal processo “7 aprile”, sorto dall’inchiesta del magistrato Pietro Calogero contro Autonomia Operaia, Toni Negri e tutti gli altri coinvolti in quella storia. Nel caso della FAI informale, siamo davanti ad un’accusa di associazione costruita in questo modo. Esiste soltanto per tre persone, ossia il numero minimo legale previsto dal reato (Cospito, Beaniamino e Gai, l’unico attualmente fuori dal carcere). È tutto molto instabile, e qui il punto politico va messo. Davanti alla FAI informale, se si pensa a come dice di strutturarsi e a come teorizza il suo modo di stare al mondo nell’universo politico, è molto difficile parlare di associazione a delinquere. Per quanto ci sia un’unione d’intenti sulle finalità (la lotta allo Stato, al capitale e così via), sulla modalità organizzativa invece la questione si fa molto più complessa. Questo, perché l’informalità di un’organizzazione politica fa sì che i suoi membri possano anche non conoscersi tra di loro: qualsiasi azione può finire sotto quell’ombrello, anche se non c’è una conoscenza diretta o un vero e proprio vincolo associativo. Per questo motivo, moltissimi degli accusati di far parte della FAI informale sono stati assolti, perché non si conoscevano tra di loro oppure hanno agito in piena autonomia. Ecco, riconoscersi in certi principi non può fare un’associazione delinquere. Altrimenti, si potrebbe traslare a tante altre cose: si pensi agli ultras, per esempio. Se ne parla spesso, ma il discorso si rivela sempre estremamente labile.
Proprio su questo punto, nel libro citi le parole di Alfredo Maria Bonanno, un importante teorico dell’anarchismo insurrezionale italiano che, nell’udienza di un processo che si svolgeva nel 1999, disse: «Tutta la mia vita negli ultimi trent’anni è stata dedicata a combattere principalmente contro la mentalità autoritaria e, guarda caso, mi ritrovo seduto su questa sedia a discutere di un’accusa di essere capo di qualcosa, e questo è quanto di peggio mi poteva capitare»…
Esatto. Dunque, come dicevi, le due cose si tengono insieme così, facendo delle inchieste che sono dei grandi calderoni in cui vengono messi in mezzo tantissimi indagati per fatti molti diversi tra di loro, distanziati nel tempo e talvolta nello spazio, da cui sorgono anche questioni di competenza territoriale. In “Scripta manent” erano decine di indagati ma, alla fine, soltanto poche, pochissime le condanne. Il punto di quest’inchiesta, a mio modo di vedere, è soprattutto politico, più che giudiziario. Il fantasma della “pista anarchica” è un concetto antichissimo (c’è chi lo fa risalire a Piazza Fontana e chi, come me, addirittura ai tempi di Sacco e Vanzetti), ampiamente strumentalizzabile a livello politico per la creazione di un nemico. In realtà l’anarchismo, in Italia come in Europa e nel mondo, non è così diffuso, o, anche ammettendo che sia diffuso, è composto di poche persone. Talmente poche che, secondo me (e parlo da cronista giudiziario che, per il proprio lavoro, ha qualche elemento a supporto), gli apparati di polizia conoscono per nome e cognome gli anarchici italiani. Poi, ogni tanto, si arriva alle strette con decine di inchieste (quasi tutte le procure hanno almeno un fascicolo aperto sugli anarchici) e i risultati, alla fine dei conti, sono miseri. Questo ci dà anche l’idea della prima questione che abbiamo provato ad affrontare. Lo stato di salute della nostra giustizia è precario anche perché, se noi pensiamo che il nostro principale nemico sia Alfredo Cospito, forse siamo un po’ fuori fuoco.
Ci sono due elementi di rottura della storia che ricostruisci: l’iniziale condanna di Cospito per strage politica alla pena dell’ergastolo; l’applicazione del 41 bis. Da lì, è nata una vicenda che si è rivelata, in un modo o nell’altro, una sequenza molto ricca: lo sciopero della fame di Cospito per più di 180 giorni contro ergastolo ostativo e 41 bis, lo slancio umanitario e legalitario della società civile, lo spettacolo della politica (basti pensare al cosiddetto “caso Del Mastro-Donzelli”) e la decisione della Corte Costituzionale, grazie alla quale la Corte d’Appello di Torino ha ridotto la pena a 23 anni di reclusione. Eppure, alla fin fine, Cospito è rimasto al 41 bis, e gli istituti dell’ergastolo ostativo e del 41 bis sono rimasti intatti nell’ordinamento. Allora, cosa ci ha portato in dote la storia di Cospito? Non potrebbe ripetersi un altro caso simile al suo, a questo punto?
Sul 41 bis il discorso è molto esteso. Parliamo di un particolare regime carcerario introdotto ai tempi delle stragi di mafia che avrebbe dovuto avere un carattere meramente transitorio, e sappiamo che così non è stato. Le istituzioni europee parlano del 41 bis come di un trattamento inumano e degradante assimilabile alla tortura, in maniera totalmente corretta a mio modo di vedere. Il 41 bis avrebbe come obiettivo quello di non far comunicare chi sta dentro con chi sta fuori dal carcere, nell’ottica di uno studio dell’epoca sul funzionamento delle organizzazioni mafiose. Ora, però, si tratta di uno strumento sempre meno efficace, e anche l’antimafia, ossia la DNA, dice che è del tutto residuale nella lotta alla criminalità organizzata, per quanto sia cambiata negli ultimi trent’anni. Quanto a Cospito, si tratta del primo e fin qui unico anarchico al 41 bis, perché è stato ritenuto il capo di un’organizzazione criminale terroristica (la FAI informale) ed è stato deciso che non possa comunicare con l’esterno. Questo ha anche dei riflessi assurdi o surreali, come il divieto di ascoltare musica “perché potrebbe ascoltare musicisti neomelodici, che sappiamo essere associati alla Camorra”. Cito storie vere, di cui si è davvero discusso davanti al Tribunale di Sorveglianza, per quanto sembri pazzesco. Poi, divieti relativi a poster, lettere, foto di familiari. Un regime di varie assurdità afflittive, più che motivate da un punto di vista di pubblica sicurezza. Purtroppo in Italia il discorso sul 41 è sempre uno spettacolo indegno, perché chiunque osi fare qualche obiezione a questo regime carcerario viene più o meno direttamente accusato di favorire la mafia. Dunque, è sostanzialmente impossibile una discussione sana sul punto. Penso soprattutto ad un politico: chiunque eviterebbe di affrontare una polemica da cui nascono accuse di presunti aiuti alla mafia; anche se è vero che ci vorrebbe più coraggio ad affrontare certi temi. Una revisione del 41 bis sarebbe necessaria anche perché se ne sta facendo un uso spropositato: sono molti più i detenuti al 41 bis oggi che durante il periodo della mafia militare, nel periodo stragista. Anche qui, sproporzioni evidenti e non più motivate dal corso degli eventi, per come sono messe le cose in Italia sul fronte della criminalità organizzata. E non lo dico io, ma sono i dati ormai ad essere molto chiari. Ripeto, basta leggere le relazioni che annualmente fa la DNA, o quanto emerge anche dalle commissioni parlamentari. E se non vengono tenuti in considerazione, è anche perché il nostro Paese ha delle derive giustizialiste paurose. Ogni revisione in senso, non dico garantista, ma banalmente costituzionale dello stato della nostra giustizia, delle nostre carceri, di come si fanno le indagini, viene visto come un attentato alla Repubblica, quando in realtà sarebbe vero il contrario. Uno Stato è tanto più forte quanto più può fare a meno di mostrare il suo braccio forte, più repressivo. Su questo, c’è tanta strada da fare ancora. Tuttavia, è vero che il caso di Cospito ha aperto qualche discussione sul 41 bis e ben oltre i confini dell’anarchismo. Se n’è parlato diffusamente, anche se non sono molto ottimista su quanto la società italiana abbia recepito certi discorsi. In ogni caso, è importante averlo aperto e continuare a parlarne. Questa battaglia si vince nell’opinione pubblica, più che tra gli addetti ai lavori, che sono abbastanza equilibrati al contrario della politica, che è assolutamente squilibrata. Bisogna insistere nel dire che il 41 bis non soltanto è una forma di tortura, ma è anche inutile, a trent’anni e più dalla sua introduzione, nella lotta contro le mafie.
Anche perché è il dibattito pubblico a rendere appetibile, dunque più facilmente percorribile, una scelta politica anziché l’altra.
Certo. E purtroppo ad oggi il dibattito pubblico in Italia è assolutamente involuto. Se ci facciamo caso, ogni Ministro della Giustizia pensa di fare una riforma con il suo nome, andando a toccare questo o quell’elemento (è indifferente quale) quando, in realtà, un buon Ministro della Giustizia dovrebbe occuparsi soprattutto di far funzionare la macchina, che è la cosa più importante e riguarda direttamente la vita delle persone. Noi abbiamo un codice penale ormai ricchissimo, la Costituzione e una marea di leggi. Non abbiamo bisogno di nuove leggi, ma di meno leggi o, quantomeno, di fare un uso più assennato e funzionale delle leggi che abbiamo. Dico una cosa da cronista giudiziario e parlamentare: spesso ci sono discorsi surreali e fuori dal mondo sullo stato della giustizia, in cui non si capisce bene il fine, se non quello di continuare una discussione infinita. Forse, in questo, trent’anni di berlusconismo e antiberlusconismo hanno inquinato le acque definitivamente. C’è ormai un sospetto reciproco tra le varie parti che rende impossibile un dialogo, quando in realtà abbiamo una buona Costituzione che dice quasi tutto quello che c’è da dire. Bisognerebbe muoversi da lì. Purtroppo, non lo fa né chi si erge a difensore della Costituzione, né chi vorrebbe cambiarla, spesso in modo fantasioso.
Alla fine di tutto, in ciò che hai raccontato ed è accaduto, quale parte credi che abbia giocato una sorta di incomprensione o equivocità dell’anarchismo, e quale invece un vero e proprio accanimento contro l’opinione?
È una domanda difficile. L’anarchismo è sempre una pentola che ribolle, c’è un po’ di tutto dentro. Ci sono tanti tipi di anarchici ed è impossibile codificare un anarchismo giusto e uno sbagliato. In Italia c’è la Federazione Anarchica Italiana (FAI italiana), che è un organismo storico, nato dopo la Seconda guerra mondiale e strutturata come federazione, con delle commissioni organizzative. Poi c’è un anarchismo antiorganizzativo, di cui Cospito è attualmente espressione. In passato, sia pure con delle differenze, lo è stato Alfredo Bonanno. Poi, ancora, tanti gruppi slegati tra di loro, individui, collettivi molto piccoli e altri un po’ più grandi. L’arcipelago anarchico è molto frastagliato, difficile da tenere insieme e da racchiudere in un unico gruppo. Nel libro affronto più gli anarchici d’azione, perché erano quelli più interessati dalle faccende giudiziarie (anche se non sono i soli, ovviamente). Il momento di rottura è difficile da individuare. È chiaro che questo Paese, avendo avuto un passato di lotta armata e terrorismo abbastanza ingombrante, ogni volta che accade qualcosa su cui si muove un certo spettro ha come dei tic, non del tutto giustificati ma neanche del tutto ingiustificati. È chiaro, però, che gli anarchici giocano molto sulla paura che incutono, a ben guardare solo in parte giustificabile appunto perché, come dicevo prima, si tratta di un fenomeno piccolo, senza una ramificazione o un consenso tanto largo. Gli anarchici possono riscuotere simpatie teoriche, per una certa visione romantica delle sue figure di cui, a dire il vero, non c’è una grande corrispondenza nella realtà. Militano in collettivi, gruppi, organizzazioni anarchiche o, per lo meno, affrontano la propria vita pubblica o privata in un certo modo, quello teorizzato da tanti pensatori dell’anarchismo e non solo, perché è impossibile definire cosa sia un anarchico oggi, o forse cosa sia in generale. Ognuno lo interpreta a modo suo. E ciò, al di là di quelli che si definiscono anarchici per lasciare intendere che sono un po’ fuori dagli schemi e dalle regole: un’autodefinizione che si danno persone che nulla hanno a che fare con l’anarchia o l’anarchismo. L’anarchico, questo possiamo dirlo, è ostile a ogni forma di potere, verso chi lo rappresenta, chi ne fa le veci e chi lo difende. Un anarchico non fa nulla per compiacere l’autorità costituita, e certamente è vicendevole. Non c’è un punto d’incontro. Io credevo di aver scritto un libro sugli anarchici, ma forse ho scritto un libro sullo Stato di diritto, perché il problema che mi sembra d’individuare è dentro i nostri uffici giudiziari più che dentro i collettivi degli anarchici, i cui problemi sono affari loro, e chi è interessato trova un’ampia pubblicistica anarchica a riguardo. Noi dobbiamo considerare come il nostro Stato, quindi gli uffici giudiziari, le procure e anche la politica, affrontano tensioni e ipotetiche piccole insorgenze, che dovrebbero farci riflettere in un’ottica generale. Entrare in un tribunale è sempre difficile, perché è impossibile capire come possano andare avanti le cose e ciò dipende da tanti fattori, spesso sconosciuti ai più. La storia degli anarchici è un’ottima cartina tornasole per evidenziare tutto questo. Al di là dell’ostilità degli anarchici, non c’è una solidità dell’istituzione pubblica nell’affrontare questi temi, quindi si ragiona sempre in un’ottica emergenziale, di dover correre, di usare il pugno duro, per combattere delle cose che forse hanno una spiegazione più politica che giudiziaria. E in quest’altro modo andrebbero affrontate, secondo me. Ma la storia mi dà torto, perché continuano ad essere affrontate nel senso opposto.
*immagine di copertina del libro “La pista anarchica. Dai pacchi Bomba al caso Cospito”

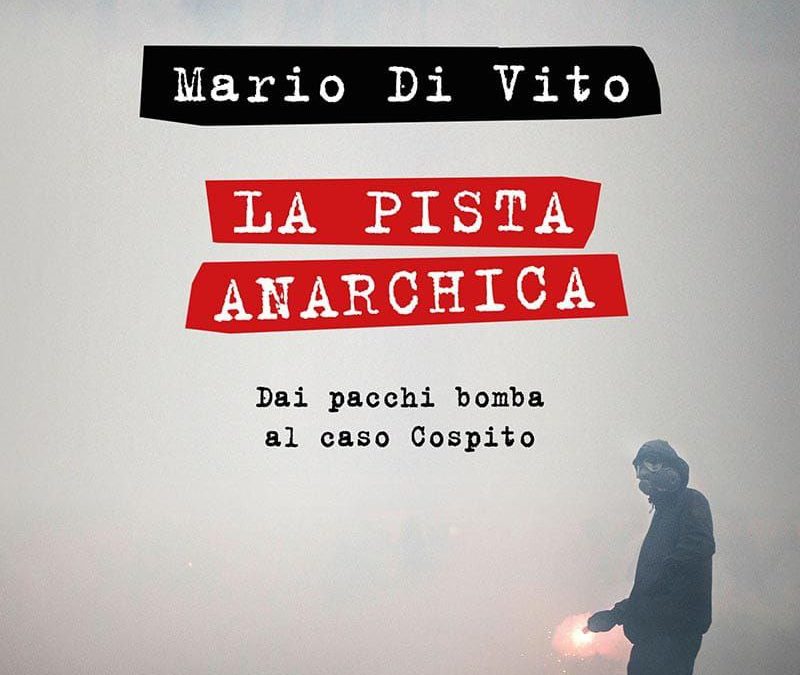
Commenti recenti