Abbiamo raggiunto telefonicamente l’Onorevole Riccardo Magi, segretario di +Europa, per affrontare insieme alcuni dei temi più rilevanti del dibattito politico attuale in materia di giustizia. Al centro della conversazione, il Decreto Legge n. 48 dell’11 aprile 2025, noto come “decreto Sicurezza”, e la proposta di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, attualmente all’esame del Parlamento.
*crediti foto in calce all’articolo
Negli ultimi anni è emersa una tendenza crescente a utilizzare il diritto penale come strumento di governo e di costruzione del consenso. Il decreto legge c.d. “pacchetto sicurezza”, di recente approvazione, pare esserne l’ennesima manifestazione. Quali sono, a suo avviso, i principali rischi di una simile impostazione politica?
Il populismo penale e l’impiego propagandistico del codice penale costituiscono tratti identitari di questo Governo. Particolarmente grave e significativo è che tali interventi vengano esplicitamente rivendicati come strumenti per “mandare un segnale”. Si assiste così all’apoteosi del populismo penale: il diritto penale ridotto a strumento simbolico di lotta. In questo modo, la gestione di qualsiasi fenomeno sociale diventa oggetto di un intervento penale, spostando pericolosamente il baricentro dell’azione politica su un piano sempre più repressivo e, al contempo, meno efficace. Peraltro, questi interventi vengono adottati mediante decreto legge, sollevando serie perplessità circa la tenuta costituzionale e l’equilibrio tra Governo e Parlamento. Le Camere risultano di fatto impossibilitate a un effettivo esame di merito, specie in ambiti delicati, come il diritto e la procedura penale, che richiederebbero maggiore riflessione e approfondimento. L’esito è la definitiva mortificazione del Parlamento. Tutto ciò è pericoloso e preoccupante, dal punto di vista degli effetti concreti ma anche della cultura giuridica e politica che esprime questo approccio.
Una delle novità più discusse è l’introduzione del reato di “rivolta all’interno di un istituto penitenziario”, punito con pene da uno a cinque anni per chi, in gruppo, opponga violenza o resistenza agli ordini impartiti. In un contesto già segnato da gravi criticità del sistema penitenziario, questa misura rischia di apparire come un’ulteriore risposta repressiva, in totale controtendenza rispetto ai principi costituzionali che dovrebbero orientare la produzione legislativa in materia penitenziaria. Qual è la sua opinione al riguardo?
L’aberrante ingiustizia che si compie in questo caso sta nel fatto che si equipara chi, pur di protestare contro quello che ritiene un suo diritto leso, adotta una scelta non violenta, mettendo in atto una forma di resistenza passiva, a chi invece aggredisce o compie atti di natura ben più grave. Viene da pensare che, a volte, questo Governo sembri avere la volontà di alimentare lo scontro all’interno della comunità penitenziaria. Invece di cercare soluzioni per le tensioni – che, del resto, sono del tutto prevedibili, poiché derivano dalle condizioni di illegalità che caratterizzano le carceri –, sembra esserci un’intenzione di esasperarle. Le condizioni di illegalità riguardano, infatti, la vita stessa dei detenuti: le strutture fatiscenti, la mancanza di spazi, l’assenza di programmi trattamentali concreti, i servizi sanitari e igienici insufficienti, e, in definitiva, la totale mancanza di dignità. Così, la detenzione diviene sofferenza continua, pura afflizione che genera solo disperazione. Di fronte a questa situazione, la risposta del governo è iper-repressiva, arrivando addirittura a criminalizzare gli atti di resistenza passiva. Ci saremmo aspettati un intervento ancora più incisivo da parte del Presidente della Repubblica.
Tra le varie misure introdotte, stupiscono in particolare le nuove fattispecie penali che sembrano rivolte a colpire forme di dissenso, come il reato di “blocco stradale”, fino a poco tempo fa un illecito amministrativo, o l’aggravamento delle pene per le “lesioni a pubblico ufficiale”, che può comportare anche l’arresto in flagranza. Queste norme sembrano essere pensate per colpire con il pugno di ferro e intimidire le persone in occasione di manifestazioni, ossia situazioni in cui, anche in modo legittimo, possono emergere conflitto e tensione. Addirittura, sembrano essere calibrate per colpire specifiche categorie di attivisti. Qual è il suo giudizio in merito?
Penso che la sua ricostruzione sia corretta e, aggiungo, che queste norme rivelano anche un tratto autoritario da parte di questo Governo. È evidente che, nella gestione dell’ordine pubblico, è cruciale come si decida di agire. La gestione dell’ordine pubblico deve garantire sia la tutela delle forze dell’ordine, sia il diritto dei cittadini di manifestare. La possibilità di manifestare è un diritto costituzionale fondamentale che deve essere protetto e reso pienamente applicabile. Mi sembra che il Governo – anche in questo caso – abbia l’intenzione di creare e facilitare situazioni di tensione, piuttosto che prevenire e gestire tali situazioni attraverso una gestione dell’ordine pubblico basata sul buon senso.
Nel “pacchetto sicurezza”, tra le altre cose, sono state introdotte misure restrittive sull’uso della canapa, anche quella a basso contenuto di THC, restringendone l’utilizzo al solo ambito “florovivaistico professionale” e criminalizzando di fatto migliaia di attività imprenditoriali. In un’Europa che va in direzione opposta, verso regolamentazione e legalizzazione, l’Italia sembra imboccare in una via isolata e ideologica. Come valuta l’operato del Governo su questo tema? Quali riforme ritiene urgenti?
Questa è una delle norme più assurde contenute nel decreto, fondata su una premessa palesemente falsa. Si afferma, infatti, che per prevenire rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, si equipara alle sostanze stupefacenti anche la canapa con un contenuto di THC inferiore. Tuttavia, è noto sia alla Corte di cassazione sia alla scienza che la canapa a basso contenuto di THC non produce effetti droganti. Si tratta di una norma puramente idologica e propagandistica, che provoca una ferita profonda nella fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Che paese è quello in cui, da un giorno all’altro, imprenditori che operano legalmente – spesso con il sostegno di fondi europei – si trovano improvvisamente trattate come narcotrafficanti? Peraltro, il contesto internazionale si muove in direzione diametralmente opposta: dalla Germania alla Spagna, dal Portogallo all’Olanda, fino ai recenti sviluppi in sede ONU, si riconosce sempre più che la regolamentazione della cannabis, anche ad alto contenuto di THC, è una strada più efficace per tutelare gli interessi pubblici. La grande differenza è che in questi ultimi casi si parla di regolamentare la cannabis con un contenuto elevato di THC, mentre questo Governo sta addirittura conducendo una “war on no drugs“: una guerra contro le non droghe. Ci batteremo affinché questa norma sia portata innanzi alla Corte costituzionale.
Spostandoci su un altro tema cruciale per la giustizia: vorremmo raccogliere il suo parere sulla separazione delle carriere.
Sono da sempre favorevole alla separazione delle carriere, ma nutro serie perplessità rispetto alla riforma in discussione. Non mi convince, in particolare, il sorteggio dei componenti togati del CSM, né la vaghezza che caratterizza molti aspetti rinviati a future leggi ordinarie e decreti attuativi. Più in generale, colpisce l’approccio del Governo, che sembra utilizzare la separazione delle carriere come strumento di scontro con la magistratura. E questo è il peggior modo di affrontare una riforma costituzionale. È anche considerare che questa iniziativa si inserisce infatti in un quadro più ampio, segnato da azioni che denotano una crescente insofferenza verso il potere giurisdizionale: dalla delegittimazione della Corte penale internazionale alla sottrazione di competenze alle sezioni specializzate in materia d’immigrazione, colpevoli di aver espresso orientamenti non graditi al Governo. La domanda che sorge spontanea è dunque se abbia ancora senso discutere della separazione delle carriere quando si assiste a interventi così invasivi sulla separazione dei poteri. Ho sempre considerato la separazione delle carriere come un passo avanti verso una giustizia più equa. Ma oggi temo che vi siano priorità più urgenti, legate a derive che ricordano le “democrazie illiberali” – che, per inciso, democrazie non sono – e che sono state pubblicamente indicate come modello da Salvini e Meloni. Ho votato a favore della riforma in prima lettura, ma al secondo voto farò una valutazione molto più approfondita perché nel frattempo tante cose sono successe.
*foto ricavata dall’articolo su Il Riformista
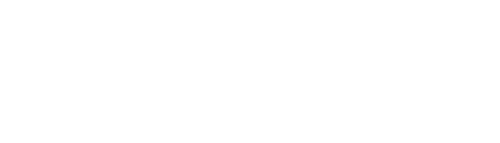

Commenti recenti