Esiste una categoria di persone che per la propria esigua rappresentatività numerica sul territorio e per le proprie specificità risulta ancora tristemente e largamente lasciata ai margini del pensiero collettivo. Si tratta delle persone transgender che si trovano in stato di detenzione e che costituiscono una minoranza non solo nel nostro Paese, ma anche a livello globale. Tale qualificazione come “minoranza” deriva non solo dalla loro condizione di persone detenute, dunque già di per sé soggette a stigmatizzazione e a isolamento, ma anche e soprattutto dalla loro condizione soggettiva di transgender. Quella dei transgender è una delle innumerevoli identità di genere che animano la comunità LGBTQ+ e che si batte per un pieno riconoscimento sociale e legale.
Nel linguaggio comune si tende normalmente ad assimilare e ad utilizzare impropriamente come sinonimi concetti che presentano delle sostanziali differenze tra loro e che, soprattutto in questo contesto, è necessario distinguere per poter comprendere fino in fondo le criticità del fenomeno del transgenderismo. Concetti fondamentali a questo proposito sono quelli di “sesso” e di “identità di genere”. Il primo consiste propriamente nella condizione di uomo o donna determinata da fattori biologici ed è dunque individuato nella persona al momento della nascita, tranne in alcuni casi limite – come quello degli intersessuali – per cui lo stesso è di ambigua definizione. Per questo motivo ci si può riferire ad esso anche con i termini di “sesso cromosomico” o “sesso genetico”. Diversamente, l’identità di genere è una percezione interiore della persona, la quale sente di appartenere all’uno o all’altro genere, il quale non necessariamente coincide con il proprio sesso così com’è biologicamente inteso. Per questa sua natura l’identità di genere è anche detta “sesso psicologico” o “sesso comportamentale” ed è un concetto fluido, soggetto a modificazioni derivanti dal continuo evolversi della società.
Compresa la prima fondamentale differenza terminologica, si può passare alla seconda grande distinzione, ovvero quella fra “transessuale” e “transgender”. Entrambe le condizioni soggettive sperimentano una non corrispondenza tra il proprio sesso biologico e la propria identità di genere e fanno parte della comunità LGBTQ+, in particolare rientrano nella macrocategoria dei “trans*”. I transessuali MtF (male to female) e FtM (female to male), anche detti postoperative transgenders sono quelle persone che ricorrono a terapie ormonali e ad operazioni chirurgiche di riassegnazione del sesso per completare il processo di transizione e riconoscersi a tutti gli effetti nel proprio genere di elezione. I transgender propriamente detti (o nonoperative transgenders), invece, sono coloro che per le ragioni più diverse scelgono di non sottoporsi ad alcun intervento chirurgico per la modificazione dei propri caratteri sessuali primari. L’assimilazione di queste due identità di genere comporta una serie di incomprensioni che rendono difficoltoso approcciarsi con la giusta sensibilità alla trattazione del fenomeno del transgenderismo.
Le principali criticità che accompagnano questo fenomeno nel contesto detentivo sono in primo luogo l’assegnazione ad un determinato settore, data l’impostazione di genere binaria cui è improntata la società moderna e di conseguenza il nostro ordinamento penitenziario; e in secondo luogo la tutela del diritto alla salute, che per le persone transgender si realizza pienamente solo in seguito all’accesso alle cure ormonali.
Il carcere, che risente delle rigide categorizzazioni di genere della società esterna, risulta essere anche una realtà fortemente declinata al maschile, nella quale i ristretti transgender – prevalentemente MtF – faticano a trovare una collocazione. Quest’ultima infatti risulterebbe potenzialmente rischiosa per gli equilibri carcerari sia se effettuata in un istituto femminile, sia in un istituto maschile. Nella prima ipotesi, infatti, si rischierebbe di compromettere la privacy e la sicurezza delle detenute donne cisgender, così chiamate perché nate biologicamente donne, ponendole in una condizione di promiscuità con detenute che pur presentando i tratti esteriori di individui dello stesso sesso, tuttavia possiedono gli organi sessuali del sesso di nascita, quello maschile. Nel Regno Unito destò particolare scalpore il caso di una donna transgender, Karen White, in stato di custodia cautelare la quale aveva aggredito sessualmente due detenute. D’altro canto, l’inserimento delle detenute transgender MtF in un reparto maschile esporrebbe le stesse al rischio di subire aggressioni verbali e soprattutto fisiche da parte della restante componente carceraria maschile. Tale rischio di aggressioni fisiche si ritiene sia oltretutto potenziato dallo stato di privazione sessuale in cui di fatto versa la popolazione carceraria in generale, pur non vigendo alcuna legge che espressamente vieti questo tipo di rapporti in carcere.
Alcuni istituti penitenziari hanno adottato la prassi molto discussa di destinare questa fattispecie di detenuti alle cosiddette sezioni protette o precauzionali, ospitanti quei detenuti che nella subcultura carceraria sono particolarmente invisi alla restante popolazione detenuta in ragione del particolare reato commesso o del proprio ruolo sociale e che a fronte della potenziale esposizione a ripercussioni fisiche vengono debitamente tenuti separati per ragioni di sicurezza. Si tratta dei cosiddetti sex offenders, autori di reati a sfondo sessuale, degli appartenenti alle Forze dell’ordine e alla magistratura e dei collaboratori di giustizia. La scelta di collocare le detenute transgender in tali reparti, in ragione esclusivamente della loro condizione soggettiva, oltre a risultare fortemente discriminatoria, pone tali ristretti nella sofferente posizione di dover subire una sorta di doppia condanna: una per il reato commesso, il quale nella maggior parte dei casi per questi ristretti risulta essere di lieve entità e di scarso allarme sociale, e l’altra per il semplice fatto di essere transgender.
In seguito al recente intervento di riforma, attuato per mezzo dei decreti legislativi nn. 121, 123 e 124 del 2 ottobre 2018, che ha investito il nostro ordinamento penitenziario (l. 354 del 1975, di seguito “o.p.”), l’art. 14 o.p. rubricato “Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati”, prevede ora esplicitamente che quei detenuti che versino in una condizione di potenziale pericolo “in ragione solo dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale” vengano destinati a sezioni protette, individuate per “categorie omogenee”. Questo intervento normativo ha di fatto solo formalizzato un approccio che in realtà era già stato adottato nella prassi da alcuni istituti penitenziari italiani proprio per evitare l’insorgere delle problematiche sopra evidenziate.
Attualmente, dunque, le persone transgender detenute in Italia (circa 56 unità secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria), appartenenti nella loro quasi totalità alla sottocategoria delle transgender MtF, vengono destinate a reparti appositamente ricavati per loro all’interno di istituti maschili (è il modello adottato dall’Amministrazione penitenziaria delle case circondariali Rebibbia “Nuovo Complesso Raffaele Cinotti” di Roma, Baldenich di Belluno, Poggioreale di Napoli, Bollate di Milano, di Rimini e di Alba) o femminili (è il caso isolato del carcere Sollicciano di Firenze). A proposito delle incomprensioni nascenti dall’errata equiparazione tra transessuali e transgender di cui si è parlato, si pensi che le sezioni cui sono destinate le persone transgender detenute in Italia sono denominate “sezioni di dislocazione destinate ai transessuali”. Il riferimento alla categoria dei transessuali risulta evidentemente scorretto, in quanto gli individui appartenenti a questo gruppo avendo completato il processo di transizione vengono destinati al settore corrispondente al nuovo sesso.
La seconda criticità, come si diceva, riguarda l’accesso alle terapie ormonali. La materia sanitaria rientra nella competenza regionale, purtroppo però non tutte le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) annoverano tale tipologia di cura tra i L.E.A. (Livelli essenziali di assistenza della sanità pubblica) stabiliti dal Ministero della salute, per cui il costo dei farmaci è garantito direttamente dalle AUSL. Per questo motivo ad oggi solo alcune regioni, nello specifico Lazio, Toscana e Emilia-Romagna hanno siglato Protocolli di intesa ministeriali fra i Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, gli Enti locali e gli Uffici dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà per poter consentire ai detenuti un libero accesso a tali trattamenti a condizione, però, che questi ultimi siano stati intrapresi già in libertà.
Il paradosso di questa situazione risiede nel fatto che il regolamento d’esecuzione dell’o.p. (D.P.R. del 30 giugno 2000, n. 230) prevede che sia l’ordinamento penitenziario stesso a doversi far carico delle spese mediche dei detenuti durante il periodo di reclusione. In questa disposizione non vengono fatte rientrare però le cure ormonali dei detenuti transgender, a nulla rilevando il fatto che tali terapie esulino da una scelta personale dell’individuo e rientrino dunque a pieno titolo nel diritto alla salute costituzionalmente tutelato all’articolo 32.
In ragione di ciò i detenuti e le detenute transgender, salvo rari casi, pagano a proprie spese la somministrazione di tali cure, la quale peraltro spesso avviene con modalità diverse rispetto a quelle adottate in libertà e che risultano alla popolazione carceraria transgender meno efficaci.
Purtroppo, come è evidente c’è ancora molta superficialità da parte delle istituzioni nel trattare l’argomento delicato del transgenderismo nel contesto detentivo.
Per tentare di andare incontro alle esigenze di questa componente minoritaria di ristretti, nel 2010 era sorta l’ipotesi di raccogliere tutte le persone transgender recluse in Italia nell’Istituto di Pozzale, nei pressi di Empoli, un piccolo carcere in precedenza destinato ad ospitare donne tossicodipendenti. Il progetto però fallì a seguito del fermo rifiuto dell’allora ministro della Giustizia, Angelino Alfano, restìo ad accogliere la possibilità di introdurre nel nostro ordinamento un istituto indirizzato ad un’identità di genere “altra” rispetto al binomio maschile-femminile.
Se allo stato attuale la possibilità che si ripresenti una soluzione come quella di Pozzale risulta poco probabile, bisogna evidenziare come al momento il modello adottato dal carcere Sollicciano di Firenze di collocare le detenute transgender MtF in una sezione all’interno dell’istituto femminile risulta quello che maggiormente si avvicina alle necessità di questa componente carceraria.
Prima di ragionare in merito alla costituzione di settori ad hoc, però, sarebbe in ogni caso fondamentale introdurre politiche di formazione ispirate alla solidarietà e al rispetto nei confronti della minoranza delle persone transgender non solo per il personale penitenziario che si trova a dover interagire quotidianamente con questi ristretti, ma anche per l’ordinaria componente carceraria e per la cittadinanza in generale.

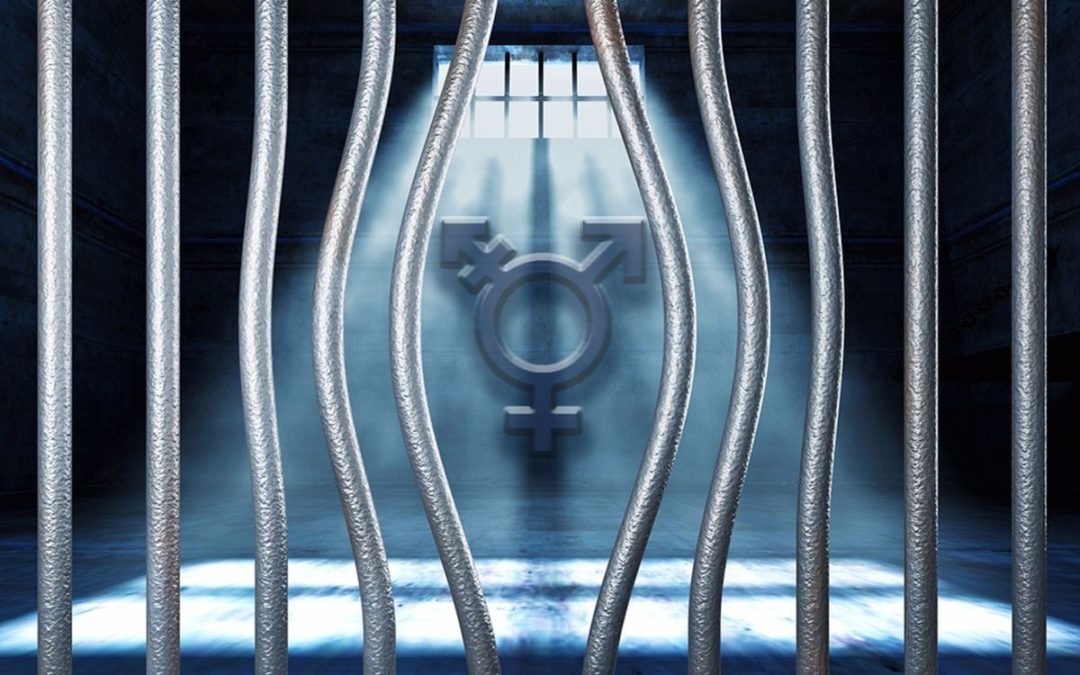
Commenti recenti